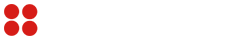CAPITOLO 3
PADOVA, 7 GENNAIO 1610
Abbiamo inoltre un ottimo ed eccellente argomento per togliere di scrupolo coloro che, pur accettando con animo tranquillo nel Sistema Copernicano la rivoluzione dei Pianeti intorno al Sole, sono però così turbati dalla rotazione della sola Luna intorno alla Terra, mentre intanto ambedue compiono l’annuo giro intorno al Sole, da ritenere che si debba respingere questa struttura dell’Universo come impossibile; perché ora, non più abbiamo un solo Pianeta rotante intorno ad un altro, mentre ambedue percorrono una grande orbita attorno al Sole, bensì quattro astri l’esperienza sensibile ci mostra erranti intorno a Giove, a somiglianza della Luna intorno alla Terra, mentre tutte insieme con Giove, nello spazio di 12 anni, tracciano un gran giro attorno al Sole.
(Galileo, Sidereus Nuncius)
PAROLE CHIAVE
Pianeti / Satelliti / Orbite ellittiche
In quella notte d’inverno, di circa 400 anni fa, uno scienziato di origine pisana, che da diversi anni era professore di matematica e astronomia all’Università di Padova, puntò verso Giove un apparecchio che aveva costruito. L’invenzione del cannocchiale non era stata sua, poiché, poco meno di un anno prima, era venuto a conoscenza, da uno dei tanti studenti a cui impartiva lezioni private, che in Olanda avevano già realizzato degli strumenti, costituiti da un tubo, entro cui erano stati messi due vetri incurvati, che permettevano di “vedere come se fossero vicine” persone o cose che si trovavano, invece, a una grande distanza dall’osservatore.
Galileo Galilei aveva immediatamente intuito le potenzialità che uno strumento di quel genere avrebbe potuto avere per una repubblica come la Serenissima, di cui Padova era parte, che temeva di essere attaccata, via mare, dalle potenze nemiche: grazie a esso, una flotta di imbarcazioni, con probabili intenzioni ostili, avrebbe potuto essere avvistata ben prima di risultare visibile, a occhio nudo, all’orizzonte. Pertanto, senza perdere nemmeno un giorno di tempo, si era fatto tagliare, incurvare e levigare da un abile artigiano, che lavorava in una delle tante e famose vetrerie di Murano, un buon numero di lenti e le aveva inserite, due alla volta, entro un tubo di piombo. Aveva poi variato la loro distanza reciproca, fino a quando non era riuscito a ottenere il suo miglior risultato: un ingrandimento delle immagini di oggetti lontani pari a otto volte il valore visibile a occhio nudo.
La dimostrazione del cannocchiale, che Galileo aveva effettuato in presenza del Doge di Venezia nell’agosto del 1609, era stata un grande successo e gli era valsa non solo la riconferma del suo incarico di insegnamento, che era soggetto ad approvazione ogni quattro anni, ma anche un considerevole aumento dello stipendio. Lo scienziato, tuttavia, non si era fermato a quel suo primo straordinario risultato e aveva continuato a modificare la curvatura delle lenti, fino a far raggiungere al suo cannocchiale i 20 ingrandimenti. Verso la fine di quello stesso anno, inoltre, aveva avuto un’idea che, oltre a cambiare radicalmente il corso della sua vita, avrebbe minato alla base e in modo definitivo il pensiero scientifico della sua epoca, ovvero quella di puntare il cannocchiale verso il cielo.
Così aveva fatto, negli ultimi giorni di dicembre del 1609, e si era molto sorpreso nell’accorgersi che esisteva una moltitudine di stelle, del tutto invisibili a occhio nudo. Oltre a questo, aveva notato che le regioni che a occhio nudo mostravano un aspetto nebulare, come la Via Lattea e la zona in cui erano immerse le Pleiadi, se osservate al cannocchiale, si rivelavano costituite, almeno in parte, da un gran numero di stelle debolissime.
Dopo aver osservato, per diverse notti, la Luna e averne stimato l’altezza delle montagne attraverso uno studio accurato delle ombre, la notte del 7 gennaio del 1610 lo scienziato pisano decise di puntare il cannocchiale verso Giove e si stupì non poco nello scorgere «tre Stelline, piccole, invero, ma pur lucentissime […] e più splendide delle altre loro pari per grandezza» (Galileo 1993, p. 31), due a est e una a ovest del pianeta.
A Galileo quella configurazione parve immediatamente poco probabile, perché le stelline erano troppo vicine a Giove e inoltre erano quasi perfettamente allineate all’equatore del pianeta, evidenze che lasciavano supporre che potessero essere corpi celesti orbitanti attorno a esso, ma lo scienziato, che sarebbe stato considerato, a ragione, l’ideatore del metodo sperimentale, non poteva trarre di certo una conclusione affrettata. Così, in perfetta coerenza con quello che era il suo modus operandi abituale, decise che avrebbe verificato quell’ipotesi con delle osservazioni successive. Del resto, sapeva che avrebbe dovuto attendere solo un giorno, poiché Giove, in quel periodo, era “retrogrado”, ossia si stava muovendo da est verso ovest, e quindi, se le tre stelline erano veramente tali e non avevano pertanto nulla a che vedere con il pianeta, la notte successiva avrebbero dovuto trovarsi tutte a est di Giove.
Non fu così, anzi, la notte dell’8 gennaio Galilei scorse tutti e tre i minuscoli corpi celesti a ovest di Giove, ovvero nel luogo in cui non avrebbero mai potuto essere se fossero state delle “stelle fisse”.
Prima di trarre la conclusione definitiva, lo scienziato volle sincerarsi che non ci fosse stato un errore nella predizione del moto di Giove e che il movimento del pianeta fosse realmente retrogrado e non, al contrario, diretto, evento che non era da considerarsi impossibile, dal momento che le tavole astronomiche erano soggette a innumerevoli imprecisioni. Galileo attese, dunque, con una buona dose di agitazione, la notte del 9 gennaio per poter escludere anche quella eventualità, ma il cielo si coprì di nubi e così dovette aspettare la notte successiva per accorgersi che Giove si trovava a ovest di due sole stelline, perché una delle tre era misteriosamente scomparsa.
A questo punto, egli non ebbe più dubbi sulla natura dei tre astri: dovevano essere, per forza di cose, in orbita attorno a Giove e quello che mancava all’appello doveva essere nascosto dal pianeta. Possiamo quasi immaginare, a 400 anni di distanza, l’emozione che deve aver colto Galileo, nel rendersi conto di aver scoperto, per caso, un nuovo centro di rivoluzione per i corpi celesti.
Egli, tuttavia, era dotato di un elevato rigore scientifico e la razionalità, in lui, prendeva sempre il sopravvento, così, prima di lasciarsi cullare dalla soddisfazione di quel risultato inatteso, decise di continuare a esaminare l’insolito sistema di astri, come scriverà lui stesso, a proposito di quanto aveva concluso nella notte fra il 10 e l’11 gennaio: «l’apparente mutamento non in Giove era riposto, ma nelle Stelle osservate; e perciò ritenni di dover da allora in poi proseguire l’indagine con maggior oculatezza e scrupolosità» (Galileo 1993, pp. 32-33).
La notte dell’11 gennaio, notò che le stelline erano ancora solamente due e si trovavano a ovest del pianeta, ma le distanze da quest’ultimo erano mutate, così come era cambiata anche la loro separazione, e comprese quindi – come scriverà riferendosi a quell’osservazione, «tanto celeri si compiono le rivoluzioni di questi Pianeti, che per lo più è possibile cogliere anche le differenze orarie» (Galileo 1993, p. 33) – che si poteva seguire l’evoluzione delle posizioni di quei minuscoli astri, a cui, come si può notare, ha già attribuito il nome di “pianeti”, anche nel corso di una singola notte.
Lo scienziato cominciò, quindi, una vera e propria campagna di osservazioni notturne, che si sarebbe protratta fino al 4 marzo dello stesso anno e che, già a partire dalla notte fra il 13 e il 14 gennaio, gli permise di stabilire che i corpi celesti orbitanti attorno a Giove non erano tre, ma quattro: uno di essi, nascosto fino ad allora dal pianeta, comparve alla vista di Galileo proprio nel corso di quella notte. A meno di un mese dal termine delle sue osservazioni, Galileo diede alle stampe un libro di poche decine di pagine, in cui riportava scrupolosamente tutto quello che era riuscito a vedere in cielo col suo cannocchiale e quanto ne aveva potuto dedurre. Il titolo che aveva scelto, Sidereus Nuncius, che si potrebbe tradurre in Annuncio sugli astri oppure in Messaggero Celeste, era di grande effetto, così come d’effetto erano, sul frontespizio, la dedica a Cosimo II de’ Medici (il figlio ventenne di Ferdinando I, da un anno succeduto al padre nella reggenza del Granducato di Toscana) e il nome Medicea Sidera, ovvero Astri Medicei, che Galileo aveva scelto di attribuire alle “quattro Lune” di Giove.
L’idea di dedicare ben quattro nuovi astri al signore di Firenze si dimostrò particolarmente felice, poiché, come Galileo aveva sperato, gli valse l’assunzione a
«Matematico Primario del Ser.mo Gran Duca senz’obbligo di leggere e di risiedere né nello Studio né nella città di Pisa et con lo stipendio di mille scudi l’anno, moneta fiorentina» e così, nel settembre del 1610, lo scienziato poté fare ritorno a Firenze, città dove aveva vissuto fin da bambino (quando il padre Vincenzo era stato chiamato a svolgere l’attività di musico alla corte dei Medici) e in cui risiedeva ancora la madre.
Nel periodo che trascorse a Padova, prima di trasferirsi a Firenze, Galileo non smise di osservare il cielo e il 25 luglio, puntato il cannocchiale verso Saturno, si accorse che il pianeta mostrava due strane protuberanze laterali. In realtà, queste non erano altro che l’anello, visto in modo “sfavorevole”, come avrebbe chiarito quasi 50 anni dopo lo scienziato olandese Christiaan Huygens nel suo Systema Saturnium, in quanto l’inclinazione reciproca della Terra e di Saturno fa apparire l’anello in forma diversa, nel corso del tempo, e può addirittura accadere che esso risulti invisibile, quando il piano equatoriale del pianeta viene a trovarsi esattamente perpendicolare alla linea di vista di chi lo osserva dalla Terra.
Facendosi influenzare da quanto aveva osservato pochi mesi prima intorno a Giove, Galileo pensò che quelle strane appendici potessero essere due satelliti di Saturno, che apparivano così “brutti”, a causa dei difetti ottici del suo cannocchiale. Per assicurarsi la paternità di quella possibile scoperta, senza però rivelarla in modo chiaro, com’era costume dell’epoca, il 30 luglio inviò a Keplero, per mezzo di Giuliano de’ Medici, che era ambasciatore del Granducato di Toscana a Praga, questa lunga sfilza non intervallata di lettere: «Smaismrmilmepoetaleumibunenugttauiras». Correttamente anagrammata, dopo aver mutato anche alcune “u” in “v” (approfittando dell’ambiguità esistente in latino tra le due lettere), avrebbe fornito il seguente risultato: «altissimum planetam tergeminum observavi», ossia “ho osservato il pianeta più alto in forma triplice”.
Keplero, che dal 1601 rivestiva a Praga il prestigioso incarico di matematico e astronomo di corte di Rodolfo II, imperatore del Sacro Romano Impero, trovò una soluzione: «salve umbisteneum geminatum martia proles», ovvero “salve, furiosi gemelli, prole di Marte”, da cui dedusse che lo scienziato pisano avesse visto col cannocchiale i due satelliti di Marte. Il latino, tuttavia, gli parve troppo barbaro, anzi, «più barbaro che latino», come avrebbe dichiarato in seguito lui stesso, e per questa ragione si convinse che la soluzione non potesse essere quella giusta e non la inviò a Galileo. Lo fece però quando, tre mesi dopo, quest’ultimo gli mandò la frase che aveva volutamente celato entro l’incomprensibile sfilza di lettere.