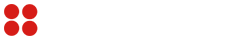2. RESPONSABILIZZARE GLI ATTORI GLOBALI
Il ruolo del diritto non è solo di resistere, ma anche di responsabilizzare gli attori globali (Delmas-Marty, Supiot 2015). Ciò significa, da un lato, rendere i divieti opponibili ai titolari del potere globale e, dall’altro, in caso di violazione, portare gli autori davanti a un giudice, nazionale o internazionale che sia. Se questo doppio obiettivo è chiaro, le modalità per raggiungerlo lo sono meno.
Una prima difficoltà è legata alla molteplicità di attori che esercitano un potere globale, in assenza di uno Stato mondiale. Non ci sono solo gli Stati e le organizzazioni internazionali, ma anche i molteplici attori della società civile: attori scientifici, ovvero gli esperti, il cui sapere è già globale; attori civili, come le organizzazioni non governative, che stimolano e sono spesso state alla base di grandi riforme, quali l’istituzione della CPI. Infine, e soprattutto, attori economici privati, ovvero le imprese transnazionali: basti pensare che i due terzi dei cento principali soggetti economici sono imprese. Ciononostante, l’accertamento della loro responsabilità giuridica è ancora essenzialmente limitato al livello nazionale. È pertanto necessario, innanzitutto, estendere la lista delle persone giuridicamente responsabili su scala globale.
Un’altra difficoltà, anch’essa scaturente dalla mondializzazione, riguarda la fragilità dell’umanità e la sua interdipendenza con gli esseri viventi non umani. Sotto l’effetto congiunto delle scoperte scientifiche e delle innovazioni tecnologiche, e sotto la pressione della questione ambientale, il diritto è ormai in prima linea nella protezione non solo delle generazioni presenti, ma anche di quelle future e degli esseri viventi non umani (animali e natura). Risulta pertanto necessario estendere la responsabilità in direzione di ciò che potremmo chiamare “il dovere di proteggere” i nuovi centri di interesse, né oggetti né soggetti, ovvero il mondo vivente non umano e le generazioni future. Si tratta dunque di un programma ambizioso di responsabilizzazione degli attori globali per evitare la disumanizzazione e la denaturazione.
2.1. L’estensione delle persone giuridicamente responsabili
2.1.1. Stati e capi di Stato
La grande rivoluzione (Zarka 2018)1Zarka, Y. C., dir. (2018) Les Révolutions du XXIe siècle, Paris: PUF. – il termine non è eccessivo – della seconda parte del XX secolo è rappresentata dall’introduzione della responsabilità degli Stati davanti a un giudice internazionale in caso di violazioni dei diritti umani. Se è vero che ciò vale solo per alcune zone geografiche, poiché non esiste una Corte mondiale, tale giurisdizione rappresenta, nelle regioni in cui esiste, una vera e propria rivoluzione. Altro aspetto fondamentale di questa rivoluzione è la possibilità di invocare la responsabilità penale dei capi di Stato – non solo ex, ma anche al potere – nel caso di commissione di crimini contro l’umanità di competenza della CPI. Se, dunque, disponiamo già di nuovi strumenti giuridici, questi sono tuttavia ancora applicati solo in parte, poco o male, poiché la volontà politica rimane incerta, se non resistente. Per quanto riguarda i capi di Stato, va ricordato innanzitutto il caso Pinochet: il generale, alla fine, è stato giudicato nel suo Paese. Miloševic, invece, è stato arrestato e sottoposto a processo internazionale, ma è morto prima di essere giudicato. Saddam Hussein è stato arrestato e giudicato, in condizioni che tuttavia è difficile definire di “giustizia equa”. Quanto a Gheddafi, la sua è stata un’esecuzione extra-giudiziaria, così come quella di Bin Laden. Per quanto imperfetta, comunque, la responsabilità degli Stati si viene delineando su scala mondiale.
La responsabilità climatica
Si tratta di uno degli aspetti più recenti della rivoluzione in corso. Focalizzandosi sui processi in cui gli effetti del cambiamento climatico sono attribuiti a Stati o a imprese transnazionali, il rapporto del Grantham Institute stima che quelli attualmente in corso siano più di 1.000, di cui 654 negli Stati Uniti e 230 ripartiti in oltre 24 Paesi. Citato in una pubblicazione del 2018 (Cournil, Varison 2018) il rapporto dà un’immagine concreta dei nuovi obblighi, la cui trasgressione comporta la responsabilità degli Stati. Tali obblighi emergono innanzitutto da una nuova interpretazione dei diritti costituzionali proposta in una serie di contenziosi divenuti “emblematici”, quali il caso Urgenda nei Paesi Bassi nel 2015 – il primo a essere avviato – e i casi Juliana negli Stati Uniti, Klimaatzaak in Belgio, così come le azioni legali promosse in Svizzera dalla Associazione delle anziane per il clima. Anche la sfera dei diritti umani è stata coinvolta in questa rivoluzione, ad esempio dalla Commissione nazionale dei diritti umani delle Filippine e dal sistema interamericano di protezione dei diritti umani con la tutela riservata alle popolazioni autoctone. Il rapporto del Grantham Institute esamina infine le prospettive di evoluzione intorno a vari strumenti emergenti, quali i «contributi promessi stabiliti a livello nazionale» (NDC o INDCs, ovvero Intended Nationally Determined Contributions), invocati davanti al giudice internazionale o in occasione di contenziosi nazionali (in Francia ma anche negli Stati Uniti). Questi contributi possono ora impegnare direttamente gli Stati.
2.1.2. Le imprese transnazionali
Per quanto riguarda le imprese transnazionali, invece, la rivoluzione deve ancora compiersi. Durante il corso abbiamo analizzato una serie di rapporti in cui si dimostra il coinvolgimento di alcune imprese nella commissione dei crimini internazionali più gravi, ovvero quelli di competenza della CPI. Tale coinvolgimento può essere indiretto, con la fornitura da parte dell’impresa di beni o servizi che contribuiscono alla commissione del crimine, o diretto, come ad esempio lo sfruttamento illegale da parte dell’impresa di risorse naturali necessarie alle proprie catene di approvvigionamento, che scatena feroci conflitti. Per molto tempo, d’altro canto, la Banca Mondiale nelle sue raccomandazioni ha considerato il rispetto dei diritti umani un ostacolo al commercio – non una reale volontà politica – in quanto gli Stati puntano soprattutto a salvaguardare i potenziali investitori, creatori di posti di lavoro. Possiamo comunque notare dei primi segnali di cambiamento: basti pensare alla recente apparizione di concetti quali la “responsabilità sociale dell’impresa” e la “responsabilità sociale condivisa”. Questi termini sono, tuttavia, ambigui. Per “responsabilità sociale” si può intendere la partecipazione del maggior numero possibile di attori alle decisioni collettive: gli Stati, ma anche gli attori della società civile. In questo senso, la responsabilità sociale dell’impresa gode di ampio consenso, ma rischia di apparire come un catalogo di buone intenzioni che funge da pretesto per disimpegnare o per deresponsabilizzare lo Stato. In realtà, questo concetto di responsabilità sociale dovrebbe portare all’accettazione dell’idea di una piena responsabilità giuridica per le imprese, che comporti quindi opponibilità e giustiziabilità nei loro confronti, esattamente come per gli Stati. Per lottare efficacemente contro i rischi di disumanizzazione, è necessario rendere i diritti effettivamente opponibili alle imprese transnazionali. Si devono inoltre migliorare molte pratiche in termini di trasparenza, identificazione del responsabile all’interno dei gruppi o ancora di imputabilità della responsabilità alle persone giuridiche; l’opponibilità è in effetti direttamente legata al tema della giustiziabilità poiché, per poter ricorrere a un giudice, è necessario poter identificare il responsabile e imputargli la responsabilità, anche se si tratta di una persona giuridica.
Il dovere di vigilanza delle imprese transnazionali
A seguito del crollo del Rana Plaza nel 2013, la Francia è stato il primo Paese ad adottare una legge sul dovere di vigilanza delle imprese madri e delle società appaltatrici, con l’obiettivo di consolidare la prevenzione contro le violazioni dei diritti fondamentali e i danni ambientali collegati all’attività delle multinazionali. Applicabile a tutte le società con più di 5.000 dipendenti in Francia o più di 10.000 in tutto il mondo, la legge del 27 marzo 2017 impone loro l’obbligo legale di identificare e prevenire le violazioni dei diritti umani e i danni ambientali che possano derivare dalle attività non solo della capogruppo, ma anche delle società da essa controllate, nonché dei subappaltatori e dei fornitori con cui queste multinazionali intrattengono consolidate relazioni commerciali, in Francia e all’estero.
Due anni dopo, il 21 febbraio 2019, un collettivo di associazioni (Les Amis de la Terre, Sherpa e i loro partner) ha presentato un inquietante bilancio dei risultati effettivi di questa legge vincolante, ancora troppo poco e mal applicata. I primi piani di vigilanza presentati dalle imprese nel 2018 sono spesso incompleti; a volte non sono stati nemmeno stilati. Nel rapporto si chiede pertanto alle imprese di rispettare maggiormente l’obbligo imposto dalla legge. Degli 80 piani di vigilanza analizzati, la maggior parte risponde solo parzialmente a quanto richiesto dalla legge, in particolare per ciò che concerne l’identificazione dei rischi di violazione, della loro localizzazione e dell’implementazione di misure atte a prevenirli. Risulta poi ancora più grave il fatto che alcune società non abbiano ancora redatto un piano di vigilanza, nonostante l’obbligazione legale esistente. Alcuni settori risultano particolarmente a rischio dal punto di vista delle violazioni dei diritti umani e dei danni ambientali: si tratta delle industrie estrattive, e dei settori degli armamenti, del tessile, agroalimentari e dei servizi bancari. Nonostante tutto, però, un progetto di convenzione dell’ONU sulle imprese e i diritti umani (2014-2019) mostra che si è avviata una spinta verso una responsabilità effettiva.
Anche in tema di giustiziabilità resta ancora molto da fare. Sul piano internazionale, si discute della possibilità di estendere la giurisdizione della CPI alle imprese. L’argomento, in realtà, non è stato trattato durante la conferenza ufficiale di revisione dello Statuto della Corte a Kampala, ma è stato discusso da alcuni docenti universitari riuniti da Emmanuel Decaux all’Università di Paris II, sulla scorta della proposta – avanzata da un gruppo di ricercatori americani – di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche davanti alla CPI. Ciò potrebbe aprire le porte alla giustiziabilità, chiaramente limitata ai casi estremi. Per i casi meno gravi, ci si dovrebbe muovere a livello nazionale. In questo caso, tuttavia, sorge un interrogativo: si dovrà privilegiare il processo nel Paese di insediamento o in quello di origine dell’impresa? Generalmente, il Paese di insediamento non ha i mezzi per condurre le indagini, mentre quello di origine, pur avendoli, spesso non ha la volontà di procedere. Rimangono dunque molti ostacoli, sia di tipo politico che giuridico.
Per superarli, la soluzione attualmente più utilizzata – che, tuttavia, non ritengo essere la migliore – è il ricorso alla competenza universale di qualche grande Stato, in particolare degli Stati Uniti. La competenza uni- versale dei giudici americani, sulla base di un testo del 1789 riscoperto negli anni Ottanta, l’Alien Tort Statute (ATS), permette di accordare una riparazione civile – non siamo in ambito penale – alla vittima di una violazione del diritto internazionale – categoria dunque vastissima – anche quando questa sia stata commessa all’estero da uno straniero nei confronti di uno straniero. Con un cambio di orientamento della giurisprudenza americana, la Corte suprema degli Stati Uniti sembra escludere la competenza universale per le persone giuridiche, limitandola alle persone fisiche. Orientamento a mio avviso non deplorevole, poiché non ritengo che il ricorso alla competenza universale sia una buona soluzione: monopolizzata da qualche Paese, rischierebbe di portare a una serie di disuguaglianze gravi e generalizzate. Immaginiamo il caos politico-giuridico in cui si precipiterebbe se il giudice di un Paese potesse giudicare secondo il proprio diritto le violazioni di diritto internazionale commesse in qualsiasi parte del mondo. Si potrebbe invece adottare una convenzione universale che conferisca la competenza al Paese di origine e preveda una serie di criteri per limitare il rinvio al Paese di insediamento, e consentire a questo di svolgere le indagini. Ma ne siamo ancora lontani. Una forte spinta per andare in questa direzione viene senza dubbio dalla pressione delle organizzazioni non governative, dei cittadini e della società civile. Possiamo verosimilmente fare la stessa considerazione a proposito dell’altra forma che illustra il processo di responsabilizzazione, ovvero l’estensione del contenuto della responsabilità.
Continua a p. 2 – 2.2. L’estensione del contenuto della responsabilità