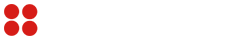Continua dalla pagina precedente
L’argomentare di Curtis, tuttavia, non si era focalizzato sull’estensione della nostra galassia, che, del resto, egli non aveva determinato personalmente, ma aveva desunto dalle stime operate da altri astronomi (che, a differenza di quanto aveva fatto Shapley, avevano sovrastimato l’effetto dell’assorbimento della luce, provocato dalle polveri presenti nella nostra galassia), ma piuttosto su tutte le diverse evidenze, che lo avevano portato a stabilire la natura esterna delle nebulae a spirale. Tra esse, si annoverava anche l’indiscutibile primato che la nebulosa di Andromeda deteneva, in relazione al numero di stelle Novae, di gran lunga superiore a quello registrato in qualsiasi altra regione della nostra galassia. A Curtis pareva molto più logico ritenere che Andromeda fosse una galassia esterna, piuttosto che una regione della nostra galassia, in quanto, se così fosse stato, la nebulosa sarebbe risultata unica, in questa sua caratteristica, rispetto a tutte le altre.
La galassia di Andromeda, M31, è osservabile anche a occhio nudo da tutte le regioni della Terra, ma apparendo molto più alta in cielo, nell’emisfero boreale, la sua visione è più facile per le regioni settentrionali che per quelle australi. Molto meno spettacolare delle due Nubi di Magellano, risulta appena percettibile, senza l’ausilio di un telescopio, e con l’aspetto di un minuscolo batuffolo di cotone evanescente. Il primo a identificarla fu l’astronomo persiano, ‘Abd al-Rahmān al-Ṣūfi, lo stesso che registrò, per primo, anche l’esistenza della Grande Nube, che chiamò Al Bakr. Nel suo manoscritto del 964, Le stelle fisse, egli descrisse e disegnò la galassia di Andromeda, a cui volle dare il nome di “piccola nube”.
La nebulosa di Andromeda sarebbe stata riscoperta più di 600 anni dopo, il 15 dicembre del 1612, da Simon Marius, astronomo tedesco, che fu allievo di Tycho Brahe e di Keplero e che sarebbe passato alla storia a causa di una disputa avuta con Galileo, in relazione alla paternità della scoperta dei quattro satelliti di Giove.
Quattro anni dopo la pubblicazione del Sidereus Nuncius, infatti, Simon Marius diede alle stampe un lavoro, intitolato Mundus Jovialis, in cui sostenne di aver identificato, qualche giorno prima di Galileo, le quattro Lune di Giove. Galileo reagì, accusandolo di plagio, ma successivamente, per ironia della sorte, i quattro satelliti di Giove avrebbero preso proprio i nomi (Io, Europa, Ganimede e Callisto) che erano stati scelti da Simon Marius.
Nonostante l’osservazione di Curtis sul numero eccessivo di Novae in Andromeda fosse più che ragionevole, proprio su Andromeda e proprio sulle Novae, anzi, su una di esse, in particolare, si concentravano le posizioni degli astronomi, che in maggioranza erano contrari alla natura extragalattica di ogni genere di nebulae, spirali comprese.
Nel 1885, era esplosa una Supernova in Andromeda, a tutt’oggi l’unica registrata in quella galassia, e l’evento era stato notato da Ernst Hartwig, che all’epoca lavorava all’Osservatorio di Dorpat, nell’odierna Estonia, lo stesso da cui von Struve aveva misurato, quasi 50 anni prima, la parallasse della stella Vega. Nessuno conosceva la differenza fra una Nova e una Supernova e tutti erano convinti che esistessero solo le stelle Novae. La presunta Nova del 1885 era risultata enormemente più luminosa di tutte le Novae, che si erano manifestate precedentemente, talmente brillante da risultare comparabile, per luminosità, alle regioni centrali di Andromeda. La maggioranza degli astronomi, che era contraria alla natura extragalattica delle nebulae, trovava proprio nella Nova il sostegno alla propria convinzione, poiché se Andromeda fosse stata esterna alla nostra galassia, la Nova avrebbe avuto una luminosità intrinseca, al massimo, del tutto inaccettabile, in quanto pari a quella derivante dalla somma di alcuni miliardi di stelle come il Sole. A loro pareva molto più logico ritenere che la stella in questione fosse una Nova e che Andromeda fosse una regione interna alla nostra galassia.
Curtis, naturalmente, non era d’accordo e vedeva la prova dell’esistenza di due diversi tipi di Novae, caratterizzati da una diversa massima luminosità, proprio nella differenza di luminosità osservata della presunta Nova del 1885 con tutte le altre Novae che si erano manifestate nel corso degli anni in Andromeda e che sulle lastre fotografiche risultavano di gran lunga più deboli.
Curtis aveva ragione, ma sarebbe trascorsa una quindicina di anni prima che Walter Baade, lo scopritore delle due diverse popolazioni stellari, e Fritz Zwicky, astronomo svizzero, che avrebbe lavorato, dal 1925, al Caltech (Californian Institute of Technology), coniassero nel 1934 il termine di “Super-Nova”, ipotizzando correttamente che il fenomeno a carattere esplosivo fosse da interpretarsi come dovuto al collasso gravitazionale di una stella che avrebbe lasciato come “relitto” un oggetto molto compatto: una stella di neutroni. Del resto, anche questa intuizione di Baade e Zwicky, che seguiva di soli due anni la rivelazione sperimentale dell’esistenza dei neutroni, non avrebbe avuto molto credito. Si sarebbe dovuto attendere il 1967, anno in cui una giovane radioastronoma inglese, Jocelyn Bell (che stava svolgendo il dottorato, sotto la direzione di Antony Hewish), avrebbe scoperto casualmente la presenza di un segnale pulsato molto regolare proveniente da M1, la Nebulosa del Granchio, e derivante dalla rapidissima rotazione della stella di neutroni, racchiusa in essa, che era quanto rimaneva dell’esplosione della Supernova, registrata dai cinesi nel 1054.
Ritornando al 26 aprile del 1920, Curtis portò a sostegno della natura extragalattica di Andromeda anche un altro importante dato osservativo, riguardante lo spettro, che l’astronomo statunitense Vesto Melvin Slipher era riuscito a ottenere diversi anni prima, nel 1912, utilizzando il rifrattore (dotato di una lente di 61 cm di diametro) dell’Osservatorio Astronomico di Lowell, situato nei pressi della cittadina di Flagstaff, in Arizona. Non era stata un’impresa facile, la sua: la quantità di luce che ci arriva da Andromeda, infatti, è pochissima e Slipher aveva dovuto esporre la lastra per un periodo di tempo che sfiorava le 40 ore. Questo significava che aveva dovuto riporre la lastra entro una scatola, al termine di ogni notte di osservazione, e riprendere l’acquisizione fotografica dello spettro (dopo aver riposizionato il telescopio in direzione di Andromeda e ricollocato la lastra al fuoco dello spettroscopio) la notte successiva. Un’operazione che si era ripetuta per una decina di notti, dal momento che, per evitare la perdita di luce, provocata dall’assorbimento atmosferico, è opportuno osservare un oggetto quando è alto nel cielo e quindi in un periodo che precede e segue di circa due ore il momento della sua culminazione.
Il risultato ottenuto da Slipher, tuttavia, si era rivelato degno della fatica spesa, poiché lo spostamento, verso il blu, delle righe di assorbimento, nello spettro della galassia, aveva rivelato una velocità di avvicinamento pari a 300 km/s. Le righe di assorbimento erano dovute al contributo di tutte le stelle di Andromeda (in quanto il gas caldo manifesta la propria presenza attraverso le righe in emissione) e, dal momento che le stelle appartenenti alla nostra galassia mostravano velocità radiali più piccole di un ordine di grandezza (tipicamente intorno ai 20 km/s), il valore che Slipher aveva misurato per la nebulosa di Andromeda, ne suggeriva una natura non locale.
Slipher non si era fermato, naturalmente, a quell’importante risultato e, nel corso dei cinque anni successivi, aveva ottenuto lo spettro di altre 24 nebulose a spirale, che avevano confermato quanto aveva evidenziato per Andromeda: tutte avevano mostrato, infatti, velocità di avvicinamento o di allontanamento dell’ordine di alcune centinaia di chilometri al secondo e, per quattro di esse, le velocità di allontanamento erano risultate addirittura superiori ai 1.000 km/s. Incredibilmente, il risultato di Slipher era passato quasi inosservato, in quanto la maggioranza degli astronomi era ostinatamente a favore di una natura locale di tutte le nebulae e di un Universo che avrebbe dovuto limitarsi a comprendere soltanto la nostra galassia.
Contro l’evidenza sperimentale di Slipher, si era espresso, invece, riscuotendo un maggiore consenso, l’astronomo, di origini olandesi, Adrian Van Maanen, che dal 1911 lavorava all’Osservatorio di Mount Wilson e nel 1916 si era messo alla ricerca di possibili mutamenti nella nebulosa a spirale M101, una galassia (che oggi sappiamo essere distante più di 20 milioni di anni luce) con un disegno talmente bello e appariscente da averle fatto guadagnare il soprannome di “Girandola”. Utilizzando un microscopio lampeggiatore, ovvero uno strumento capace di alternare la visione di due lastre, Van Maanen aveva confrontato alcune lastre fotografiche di M101, prese in anni diversi, e le differenze, che egli sosteneva di aver visto, relativamente alla posizione di alcune stelle molto luminose, lo avevano indotto a ritenere di essere riuscito a osservare la rotazione delle braccia della nebulosa attorno al centro. L’astronomo olandese ne aveva concluso che M101 dovesse appartenere, senza ombra di dubbio, alla nostra galassia, perché, se fosse stata una nebulosa esterna, le stelle localizzate nelle sue braccia avrebbero ruotato a una velocità superiore a quella della luce che, in accordo con quanto stabilito dalla teoria della relatività ristretta e verificato dalle osservazioni, costituisce un limite massimo e invalicabile.
Cinque anni dopo, nel 1921, Van Maanen avrebbe sostenuto di aver osservato la rotazione delle braccia di altre tre nebulose a spirale e Shapley, all’epoca già direttore dell’Harvard College, si sarebbe complimentato con lui, inviandogli un biglietto, dal seguente contenuto: «Congratulazioni per i risultati sulle nebulose! Abbiamo messo un freno agli universi isola, lei avvicinando le spirali e io espandendo la Galassia. Siamo davvero bravi, noi!» (Hoskin 2001, p. 259).