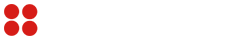7. Polivocità e allegoria
La concordia si realizza dunque a partire dall’analisi delle strutture della conoscenza umana accessibili attraverso una ricerca lessicale e un’analisi filosofica del linguaggio. Le operazioni sul linguaggio, la contestualizzazione dell’usus loquendi, lo scavo oltre la «corteccia dei termini» non potranno condurre al senso unico e definitivo del referente, ma sono uno strumento preliminare e ineludibile per rintracciare la corrispondenza e la compatibilità delle tradizioni. La parola, il discorso, il linguaggio, non sono costitutivi del sapere inteso come ricerca (inesauribile e ineffabile) della verità, ma sono essenziali a riconoscere quella struttura concordista del pensiero umano e della sua storia, che è precondizione del sapere. È vero che manca in Pico l’idea di una specularità tra strutture del discorso e strutture del pensiero, paragonabile a quella del Poliziano. Ma resta vero, anche per Pico, che ratio e oratio sono manifestazioni insopprimibili ed esclusive dell’umanità e indicano, nell’uomo, il criterio per l’organizzazione dei saperi.
La concezione dell’uomo che Pico aveva sostenuto nell’Heptaplus può aiutare a capire le ragioni di questa operazione. Ancora una volta il punto di partenza è il linguaggio: nel libro della Genesi sono contenuti tutti i segreti della natura, custoditi però sotto un «rudis cortex verborum». La ragione di questo nascondimento sta nel fatto che i più saggi tra gli antichi sapevano che era necessario mantenere gli arcana naturae celati ai più, o tramandandoli solo per via orale in modo da raggiungere, nel loro nitore, solo gli iniziati e dissimulandone (dissimulanter) il senso ai profani attraverso una scrittura oscura (Pico 1942, p. 1731Pico, G. (1942) De Hominis dignitate, Heptaplus, De Ente et Uno e scritti vari. Edizione a cura di E. Garin. Firenze: Vallecchi.).
La dissimulazione della verità sotto un linguaggio elusivo ha ragioni ben precise. In primo luogo il senso comune resterebbe sconvolto e accecato di fronte alla verità supreme: «Mosè – scrive Pico – portava dunque la luce per giovare ai sani, ma la portava nascosta e velata per non offendere gli uomini di vista debole» (Pico 1942, p. 180). In secondo luogo il «velo» non è che il prodotto determinato dal carattere inesauribile del testo. La ricchezza di un discorso capace di contenere «i veri tesori di tutta la filosofia» si riflette nell’oscurità del linguaggio e nella difficoltà di pervenire alla sua completa esplicazione: «tale è la vastità e fecondità del campo che nessun numero di mietitori è adeguato alla raccolta» (Pico 1942, p. 179).
La polivocità della Genesi comporta, secondo Pico, il problema di definire un criterio di interpretazione unico, capace di cogliere in modo coerente il testo senza forzarlo, all’interno di un quadro interpretativo che dimostri la validità dell’argomentazione allegorica. È qui che l’idea dell’uomo come mediomondo – e come centro di una libertà che scaturisce dal conflitto – diventa assolutamente determinante. Per quel che riguarda la validità del discorso allegorico, esso esprime in modo simbolico quei vincula concordiae che sono alla base della struttura ontologica della realtà. I tre mondi che definiscono la struttura del reale nell’Heptaplus – quello intelleggibile, quello celeste e quello terrestre – sono legati insieme «da un certo armonico legame di natura e da un ordinamento per gradi» che ne determina l’unità (Pico 1942, p. 188). «Legati da vincoli di concordia, tutti questi mondi si scambiano con reciproca liberalità come le nature così anche le denominazioni» (Pico 1942, pp. 191-193): ogni disciplina dell’interpretazione allegorica – secondo Pico – deriva da questo principio.
L’allegoria è dunque un metodo esegetico che marca un’ulteriore differenza teorica rispetto a Ficino. Coerentemente con l’impostazione teologico-platonica del proprio pensiero, Ficino privilegia il metodo anagogico, il processo interpretativo ascendente che utilizza ciò che è basso per accedere a significati via via superiori, in luogo della corrispondenza orizzontale e bilaterale dell’allegoria pichiana. Un’interpretazione gerarchizzante, quella anagogica, circolare o lineare quella allegorica.
L’allegoria coglie ed esprime attraverso «immagini» e «figure» le relazioni su cui si struttura la realtà, ma il punto essenziale di questo metodo è il suo centro e il centro è l’uomo, il quale può comprendere i vincula tra i mondi e i piani dell’universo, giacché egli non è soltanto «un quarto mondo, quasi una creatura nuova, quanto il complesso e la sintesi dei tre mondi descritti» (Pico 1942, p. 301). L’uomo è «complexus» e «colligatio», perché contiene in sé «le forme e le ragioni di tutte le cose» e può riunirle e connettere (corrogat et counit): se Dio è il principio del reale, l’uomo è «il termine medio di tutte le cose» (Pico 1942, p. 301).
Il problema della libertà si lega dunque profondamente a quella «ambiguità» che può caratterizzare il mediomondo come «tramite e punto di articolazione tra gli altri due altri mondi, quello trascendente e quello naturale» oppure come «cesura tra quelle due polarità opposte» (Angelini 2011, p. 772Angelini, A. (2011) Il «doppio ritratto» di Francesco Barozzi, Philosophia, III-IV: 53-77.). L’uomo è «vincolo e nodo delle cose celesti e terrene […], purché sia in pace con se stesso» (Pico 1942, p. 305); ma quella libertà con cui può tendere verso un dio ineffabile, insieme alla radicale distanza che lo separa dalla verità, è la stessa che lo condanna alla caduta e al peccato e al rischio di unirsi a «quelli che (come disse l’oracolo) si aggirano intorno alla terra e al mare e sempre vengono puniti», perché «rei d’aver violato l’universo e la maestà divina» (Pico 1942, p. 307). Nello scegliere il male, l’uomo, il mediomondo, da punto di sintesi diviene lo strumento di una lacerazione capace di spezzare l’ordine stesso di tutte le cose: nei libri dei profeti quando si riporta un comando o un divieto di Dio si invocano a testimoni il cielo e la terra, poiché «la violazione della legge offende anche loro» (Pico 1942, p. 307). La scelta, che è l’elemento che segna la condizione umana, non può dunque essere che tragica: «noi dobbiamo finire in uno di questi due modi, o in somma miseria, o in suprema felicità» (Pico 1942, p. 339).
Diventa così più chiaro come mai l’altra faccia del «magnum miraculum» dell’Oratio sia quella dell’«omuncolo», qualcosa di simile a un pipistrello incapace di vedere e riverso al suolo: «Noi omuncoli – si chiederà Pico nelle Disputationes, a proposito del problema della provvidenza – anzi pipistrelli, talpe, asini, bovi, piegati a terra, giudicheremo tutto ciò chiamando in esame Dio stesso?» (Pico 1946, p. 444). «Stranamente nessuno ha notato – osservava Eugenio Garin in un suo saggio del 1990 – che qualche decennio prima che Giovanni Pico della Mirandola componesse la famosa apertura ermetica dell’orazione in lode dell’uomo, l’Alberti ne aveva già scritta la parodia» (Garin 1990, p. 1453Garin, E. (1990) La filosofia come sapere storico, Roma-Bari: Laterza.). Ma neppure Leon Battista Alberti, il pensatore che «rovescia l’antropologia del-la tradizione umanistica ed ermetica» e che fissa per l’uomo «un limite che è insuperabile perché, sprofondando nella realtà stessa dell’universo, è di carattere strettamente ontologico» (Ciliberto 2002, pp. 113-1144Ciliberto, M. (2002) L’occhio di Atteone: nuovi studi su Giordano Bruno, Roma: Edizioni di storia e letteratura.), avrebbe utilizzato parole così dure per descrivere l’abisso che separa il finito dall’infinito, l’uomo da Dio.
In Pico il limite ontologico tra il finito e l’infinito, quella distanza in cui si gioca la sua libertà, ma anche lo strappo che lo esilia sia da Dio sia dalla natura, corrisponde alla distanza tra la parola e «la grotta di Eraclito», ovvero il silenzio della verità colta nella sua purezza. Diversamente da Giordano Bruno per cui non vi è alcuna mediazione capace di superare la «disproporzione tra l’uomo e Dio» (Ciliberto 2007, p. 1375Ciliberto, M. (2007) Giordano Bruno. Il teatro della Vita, Milano: Mondadori.), per Pico la dialettica tra la parola e il silenzio esprime sia la distanza tra il finito e l’infinito, sia la possibilità che l’uno oltrepassi nell’altro. Il silenzio testimonia l’abisso che separa l’uomo dalla verità, ma è anche il punto in cui si concentra quella tensione che spinge l’uomo a diventare «unum cum deo spiritus facto». Si tratta qui di cogliere quello che i linguaggi della ragione non possono descrivere e che può solo essere indicato in modo oscuro dai linguaggi della teologia negativa o dai grandi miti. Non a caso, nell’Oratio, a parlare era stata l’immagine poetica di un dialogo tra Dio e Adamo, sola forma espressiva in grado di indicare una dimensione della conoscenza in cui le aporie della ragione si sciolgono per risolversi nel luogo in cui la libertà dell’uomo si realizza nella sua compiutezza e cessa finalmente di essere inquieta ricerca della verità.
Il progetto filosofico di Pico partiva dagli interrogativi posti dal platonismo di Pletone e di Ficino, declinandoli in una prospettiva completamente nuova. Alla destabilizzante riscoperta della prisca antichità, il giovane Conte non opponeva la ricostruzione di un passato identico, da ristabilire e mantenere intatto, bensì un concetto di libertas philosophandi in cui la funzione del filosofo non fosse quella del custode del passato, bensì quella di indagatore delle incoerenze, giudice delle probabilità, nuovo artefice di una concordia filosofica che si poneva come progetto originale alla luce del quale reinterpretare il passato e progettare un’età nuova.
Il risultato doveva essere una nova philosophia – l’espressione è di Pico nell’Oratio – in grado di porre al centro i problemi dell’interpretazione allegorica, della razionalizzazione del simbolo, dello studio storico della filosofia. All’inevitabile provvisorietà e storicità dei linguaggi umani occorreva fare fronte con gli strumenti della ragione e dell’intelletto e non ricorrere all’ipostasi di un’origine immobile e altera, capace di proiettare nei secoli la luce di una verità sempre identica. Interrogandosi sulle forme del mito, sui testi sacri e sui grandi filosofi, era uno sguardo nuovo e attivo teso a ricostruire, ridisporre e reinventare un sapere che definiva come proprio criterio di validità non più la sua antichità, ma la correttezza argomentativa, testata e validata in pubblica discussione dalla comunità dei dotti.
Il risultato immediato che Pico ottenne fu il fallimento del grande progetto romano e la propria condanna per eresia, triste destino – commentava amaro il filosofo nella sua Apologia – che «sempre accade a chi costruisce qualcosa di nuovo e non banale» (Pico 2010b, p. 5). L’istanza che lo animava si opponeva però non solo a questioni legate alla censura e agli scontri con la Chiesa; il vero problema riguardava le condizioni di possibilità di uno sforzo interpretativo volto a conciliare in una nuova sintesi la grande discordia delle tradizioni del passato. Per edificare il nuovo edificio del sapere, capace di contenere le differenze che si presentavano nella storia del pensiero, bisognava interrogarsi in primo luogo sulle possibilità dei linguaggi della filosofia e sui metodi della trasmissione del sapere, problemi questi che nella riflessione di Pico sul mito torneranno con sempre maggiore urgenza.
Anche a questo proposito può essere utile il confronto con la posizione maturata da Pletone e in parte ripresa dal Ficino. L’idea di prisca theologia comportava due modalità di trasmissione del sapere: la prima coincideva con la tradizione orale, la seconda con la possibilità di un’intuizione intellettuale del vero, metastorica e immutabile. Dal punto di vista teorico i due aspetti si implicavano a vicenda. L’antica saggezza – la verità dell’origine – era stata trasmessa oralmente perché il sapiente doveva possedere la scienza «nell’anima, e non nei libri» (Pléthon 1989, pp. 377-3786Pléthon, G. G. (1989) Contre les objections de Scholarios en faveur d’Aristote (Réplique), Byzantion, 59: 354-507.); la relazione profonda tra “antichità” e “interiorità” indicava che la verità si nascondeva tanto nelle profondità del sé, quanto nei recessi della storia. Lo stesso legame poneva la possibilità dell’uomo di avere un’intuizione diretta e metastorica della verità; di qui l’uso di Pletone del concetto stoico di κοιναὶ ἔννοιαι ricavato da Alessandro di Afrodisia: opinioni comuni, criteri di verità, ἀξιώματα che derivavano da un’intuizione razionale capace di prescindere dalla temporalità dei linguaggi e dei saperi umani (Masai 1956, p. 115 ss.7Masai, F. (1956) Pléthon et le Platonisme de Mistra, Paris: Les Belles Lettres.).
Pico comprendeva i problemi legati al discorso sulla trasmissione orale del sapere e al rapporto tra la filosofia e il mito: in negativo vi era il rischio di trasformare la filosofia in una serie di «inextricabilia commenta», come scriveva nel De Ente et Uno; in positivo si poneva il compito di cercare di definire i metodi e gli strumenti attraverso i quali la filosofia potesse svelare il senso «sottile e alto» del mito per non confinarlo nel campo delle istorie. Un esempio di cosa intendesse Pico lo troviamo in un altro frammento polemico rispetto a Ficino: «vi sono cose – aveva scritto Ficino nel suo trattato Sull’Amore – che, narrandole come istorie, molto più mostrano la forza e lo imperio di Amore, che volendo a quelle sensi allegorici dare» (Ficino 2003, p. 268Ficino, M. (2003) Sopra lo amore ovvero Convito di Platone, Milano: SE.). Ficino si riferiva all’allegoria di Alceste e di Orfeo, a un punto fondamentale dell’interpretazione pichiana del Simposio, e forniva un’interpretazione rispetto alla quale, ovviamente, il Conte si trova in totale disaccordo: esisteva un senso «sottile e alto» del ricorso al mito di Alceste che, secondo Pico, era totalmente sfuggito a Ficino e si trattava di un senso «alle cose tanto conforme che quasi maraviglia mi pare che e Marsilio e ogni altro, preso dalle parole di Platone, non l’abbia inteso» (Pico 1942, p. 556).