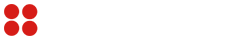6. Linguaggio figlio della guerra
La verità, per Pico, è una meta remota alla quale tendere, pur senza garanzie; per questo, scrive nell’Oratio, non sarebbe degno «sapere solo di riflesso», senza dire niente di proprio, senza provare a costruire una propria nova philosophia. A cosa servirebbe, si chiedeva ancora, «aver discusso tutte le altrui opinioni se, accedendo al convito dei sapienti come chi non rechi la sua parte, non avessimo portato nulla di nostro, nulla prodotto ed elaborato dal nostro ingegno?» (Pico 1942, pp. 142-145). Occorreva dare un qualcosa che potesse almeno «accennare» (innuere) alla verità. Qui sta il freno che Pico pone contro ogni deriva scettica, ma qui sta anche il fondamento di un sapere umano che non si accontenta di ritornare all’origine, orfano, ma proprio per questo libero da ogni idea di verità rivelata, perenne e immutabile.
Posto il carattere trascendente della verità, il suo darsi parziale e molteplice nella storia e la necessità di ripercorrere tutte le vie, in una ricerca che dovrà necessariamente condurre a un proprio percorso, resta il problema di organizzare quei saperi in una struttura tale da mostrarli esattamente per ciò che sono. Sentieri interrotti della ricerca del vero, tutti degni, tutti con qualcosa di specifico e proprio, tutti indispensabili a intraprendere un percorso di libertà che l’uomo vive scegliendo di cercare la verità.
Anche per questo nel De Ente et Uno il criterio organizzativo attorno al quale ricomprendere tradizioni diverse diventa l’uomo: intorno a lui e al suo modo di conoscere Pico cercherà di organizzare un sistema capace di contemplare in sé il carattere molteplice delle tradizioni, accettando la forma, sempre congetturale, della conoscenza umana e la condizione, grandiosa nella sua tragicità, che fa dell’uomo un punto di totale indeterminatezza.
Il problema di risolvere la contraddizione del darsi della verità nella storia diventa in Pico quello della definizione delle possibilità e dei modi attraverso cui l’uomo può attingere alla verità. Il percorso per ricercare la concordia appare così come l’esercizio del filosofo che ripercorre le tradizioni del passato come tentativi tesi a una verità avvicinabile da tanti lati, sebbene in sé inesauribile.
È a questo livello che la questione del linguaggio si pone come problema costitutivo dei modi e dei limiti del conoscere umano. Di fronte al problema di porre le basi metafisiche della concordia Platonis et Aristotelis, nel De Ente et Uno, segue le tappe di un «itinerarium mentis ad Deum» (Garin 1937, p. 119), che delimita i confini della conoscenza razionale e di quella intellettuale e che pone, infine, nel silenzio il limite ultimo che l’uomo incontra nel suo tendere verso la verità.
La verità assoluta resta l’enigma che rivela il carattere aporetico di ogni umano sapere. Nel De Ente et Uno il linguaggio della mistica è al centro di un’analisi volta a comprendere quale tipo di discorso, quale «loqutionis rationem» giustifichi il senso della trascendenza in filosofie come quella dello Pseudo-Dionigi. A Pico però non sfuggono i problemi legati alla comprensione e all’uso, in filosofia, di un linguaggio separato dalle strutture argomentative della ragione. Il rischio, scrive ben chiaro, è quello di «uscircene con immaginifiche (somnia) e incomprensibili (inextricabilia) trovate» (Pico 2010, p. 246).
È il limite che Pico pone alla filosofia, definendo il carattere ipotetico di qualsiasi posizione, ciò che gli consente di salvarla dall’annientarsi in un sapere totalmente slegato dalla ragione. Il dovere del filosofo rimane quello del vaglio critico e razionale delle tesi sostenute dalle diverse scuole filosofiche e teologiche, con la consapevolezza però che tale confronto può di fatto aspirare soltanto a definire il grado di probabilità delle tesi esaminate, senza mai poter soddisfare il desiderio umano di giungere alla piena verità.
Nella lettera del 6 dicembre 1484 a Ermolao Barbaro, Pico aveva anticipato l’intenzione di lavorare al progetto della concordia Platonis et Aristotelis. Giunto a Firenze non come «transfuga», ma come «explorator», esprimeva la convinzione che la discordia tra le grandi tradizioni della filosofia occidentale fosse solo apparente: «si verba spectes, nihil pugnantius, si res, nihil concordius» (Pico 1942, p. 9). Il fine di quella ricerca – come spiegherà nell’Oratio – era il superamento della discordia e della quiete di una «pace perpetua». «La pace che Dio attua nei suoi cieli» – avvertiva però il filosofo – quella che si manifesta solo per la «santissima teologia» ed è ben altra cosa rispetto alla pace che l’uomo può trovare nel suo mondo e in quello della natura. Come in Eraclito la natura è «figlia della guerra»; è la contentio di cui ha parlato Omero, è senza quiete né pace (Pico 1942, p. 119). Proprio per conoscere questa «figlia della guerra», Pico porrà al centro della propria filosofia – cercando di superarlo – il problema della distanza tra le parole e le cose.
Dietro alla maschera della contraddizione verbale si cela, per Pico, una verità nascosta dal fatto che talvolta il linguaggio non svela, bensì occulta. Dalla riflessione sul linguaggio dipendeva dunque sia la possibilità di ammettere fino in fondo la discordia, sia quella di superarla.
Queste istanze vengono tematizzate alla metà degli anni Ottanta nello scambio epistolare con Barbaro De genere dicendi philosophorum. Il movente di quel giro di lettere resta controverso. Per Eugenio Garin la lettera di Pico Barbaro del 3 giugno 1485 costituiva «un vero e proprio trattatello filosofico in difesa della pura speculazione contro le pretese dei grammatici» (Pico 1942, pp. 7-8). L’indiscutibile tono “retorico” dell’epistola ha dato luogo a letture diverse che hanno considerato lo scritto pichiano piuttosto come un gioco letterario. Francesco Bausi ha sostenuto «una terza linea interpretativa» che, «mentre accerta le indubbie componenti retoriche (e quindi ironiche, ludiche, parodiche) della lettera pichiana e dell’intera discussione, porta nondimeno alla luce, al tempo stesso, i precisi, reali e non trascurabili motivi di dissenso tra il Barbaro e il Mirandolano» (Bausi 1998, pp. 1-21Bausi, F. (1998) Introduzione. In: E. Barbaro, G. Pico della Mirandola, Filosofia o eloquenza?, Napoli: Liguori, pp. 1-33.). Sempre Bausi ha giustamente insistito sul «carattere intimamente anfibologico del discorso del filosofo barbaro» e mostrato come nella lettera di Pico «la forma sembra muoversi in direzione opposta al “contenuto”, comunicando un “messaggio” antitetico a quello affidato al piano del discorso logico» (Pico, Barbaro 1998, p. 132Pico, G., Barbaro, E. (1998) Filosofia o eloquenza?. Edizione a cura di F. Bausi. Napoli: Liguori.). È proprio questa tensione dialettica profonda, questa contrapposizione tra «forma» e «contenuto», il grande tema della lettera, ossia quello del rapporto tra verità ed espressione, tra verità e linguaggio.
La questione di salvaguardare la specificità delle più varie dottrine filosofiche si traduce, nell’epistola De genere dicendi al Barbaro, nel tema della correlazione tra retorica e filosofia. Definire la retorica «quasi altera pars» della filosofia, ossia porre un «mutuus nexus» tra parola e pensiero, significava da un lato riprendere la tesi ciceroniana secondo la quale solo il sapiente è davvero eloquente, ma dall’altro rischiava di escludere come non filosofica tutta la tradizione del pensiero medievale e, più in generale, tutte le tradizioni di pensiero lontane dall’eleganza del latino umanistico. Era questa una conseguenza inaccettabile per una filosofia come quella di Pico, volta a fondare un nuovo edificio del sapere sufficientemente ampio e versatile da potere accogliere tutte le tradizioni, mostrandone sia i punti di convergenza, sia le particolarità con le quali ciascuna offriva un proprio e specifico contributo alla ricerca del vero.
Pico, in ciò scolaro del Bessarione, rivendica il primato e la specificità della filosofia e, sulla scorta del Cardinale bizantino, la sua rivendicazione si rifà a Cicerone, chiamato in causa in due passi fondamentali della lettera (Mohler 1923, p. 493Mohler, L. (1923) Kardinal Bessarion Als Theologe: Humanist Und Staatsmann. Funde und Forschungen, 3 voll., Paderbon: Schöningh.). Seguendo il De finibus (I, 5, 15), Pico asserisce come al filosofo sia richiesta sapienza e non un bello stile: «non desiderat Tullius eloquentiam in philosopho, sed ut rebus et doctrina satisfaciat» (Pico, Barbaro 1998, p. 51). Ma anche nel caso in cui si volesse ammettere la tesi del mutuus nexus di sapienza ed eloquenza, il primato della filosofia rispetto al sermo resta fuori discussione, giacché al filosofo che tradisse questo assunto resterebbe «una saggezza non eloquente», mentre al retore non rimarrebbe altro che «una stolta loquacità» (Pico, Barbaro 1998, p. 58).
La lettera al Barbaro del 3 giugno 1485 sviluppa una riflessione sui limiti del linguaggio che è alla base di un nuovo modo di fare filosofia. Scrive Pico che i nomi delle cose sono stabiliti o per convenzione (arbitrio) o per natura. Tre delle ottanta Conclusiones philosophicae secundum propria opinionem vertono proprio su questo problema e aiutano a comprendere meglio la posizione di Pico. Nella tesi trentadue Pico pone la distinzione tra un «quid nominis» e un «quid rei» e afferma esserci scienza dimostrativa solo conoscendo il soggetto e l’oggetto in termini di realtà, solo penetrando in rerum natura, fino a raggiungere un livello costitutivo, non meramente convenzionale. La tesi cinquanta, che funge quasi da corollario a quella che la precede, chiarisce la natura convenzionale del linguaggio spiegando l’origine dei nomi «ex sola voluntate impositione». L’ultima tesi di questo gruppo è forse la più significativa perché afferma che solo a una lingua, quella ebraica, è possibile attribuire lo statuto di «lingua prima et non casualis» e ammette, quindi, che in essa il «quid nominis» coincida con il «quid rei» (Pico 1995, p. 70).
Va detto che il problema qui sollevato da Pico interessa tutta la filosofia del Quattrocento proprio a partire dalla riflessione sul rapporto tra res significatae e significationes verborum sul quale Lorenzo Valla aveva concentrato il suo grande progetto di deontologizzazione del linguaggio (Camporeale 19864Camporeale, S. (1986) Valla, retorica e linguaggio. In: O. Besomi, M. Regoliosi, a cura di, Lorenzo Valla e l’Umanesimo Italiano, Padova: Antenore.).
La lettera a Ermolao contiene un’indicazione preziosa riguardo ciò che Pico intende quando difende una conoscenza capace di addentrarsi nella realtà delle cose: anche ammettendo che i nomi traggano direttamente la propria «rectitudo ex natura rerum», occorrerà indagare le cose stesse, o rivolgersi a chi le ha studiate, e non sarà sufficiente limitarsi a consultare i grammatici (Pico, Barbaro 1998, pp. 56-58). Indagare le cose significa attingere a quel «quid rei» a cui i nomi rimandano per mera convenzione senza esplicarne la verità.
Cosa significasse però per Pico rivolgersi alla natura si fa più chiaro in alcuni passi delle Disputationes. Come si è visto, la dimostrazione della falsità delle «favolosissime immagini» utilizzate dagli astrologi consiste precisamente nel fatto che di esse non possiamo avere conoscenza «neque sensu neque ratione» (Pico 1946, p. 276). Inoltre, l’osservazione empirica degli influssi astrali è risultata essere di per sé «qualcosa di infinito, non riducibile né a metodo né ad arte alcuna» (Pico 1946, p. 464): per questo l’astrologia divinatrice non può avanzare alcuna pretesa di scientificità. Ma ciò significa anche che è possibile una conoscenza cui l’uomo può e deve tendere; una conoscenza congetturale della natura, basata sull’unione di senso e ragione. La distanza che separa il linguaggio dalla natura pare quindi in qualche modo essere superata dall’esperienza diretta delle cose, condotta secondo metodo e guidata da principi razionali.
Ma esiste, secondo Pico, un’insufficienza del linguaggio più profonda, strutturale, che pone un abisso tra l’uso linguistico e la verità intesa nella sua assolutezza. A livello ontologico il problema era radicale: in primo luogo perché la distanza tra un principio eterno – il vero – e uno strumento storico – il linguaggio – è incolmabile. In secondo luogo perché il linguaggio umano può muoversi solo per determinazioni ed esclusioni, quindi non può cogliere una verità “assoluta”.
Nella lettera a Barbaro del 3 giugno 1485 Pico accenna a questo motivo, che diventerà centrale nel De Ente et Uno, paragonando la verità all’«antro inospitale di Eraclito» (Pico, Barbaro 1998, p. 52) al quale ha accesso solo chi ha «Mercurio non sulla lingua ma nel cuore» (Pico, Barbaro 1998, p. 40). Il vero è «un punto matematico, uno e indivisibile» (Pico, Barbaro 1998, p. 54) che il linguaggio non può cogliere e l’eloquenza, quella che il filosofo non può disprezzare, va cercata «in animo et non in labris» (Pico, Barbaro 1998, p. 40).