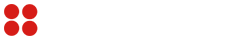CAPITOLO 7
LA VERA NATURA DELLE NEBULAE
The question whether nebulae are external galaxies hardly any longer needs discussion. It has been answered by the progress of discovery. No competent thinker, with the whole of the evidence before him, can now, it is safe to say, mantain any single nebula to be a star system of coordinate rank with the Milky Way. A practical certainity has been attained that the entire contents, stellar and nebular, of the sphere belong to one mighty aggregation.
_ . _
Il problema se le nebulose siano o no galassie esterne non richiede più alcuna discussione. Esso ha trovato risposta nel progresso del sapere. Nessun pensatore competente, che avesse tenuto adeguatamente in conto l’intera evidenza accumulatasi nel tempo, potrebbe, ora, affermare che le nebulose possano essere sistemi stellari di rango paragonabile a quello della Via Lattea. È stata raggiunta una concreta certezza del fatto che tutti i contenuti, stellari e nebulari, appartengono a un’unica possente aggregazione.
(Agnes Mary Clerke, The System of the Stars, 1890)
PAROLE CHIAVE
Candele standard / Galassie / Universo
La sera del 26 aprile del 1920, nel Museo di Storia Nazionale di Washington, Harlow Shapley e Heber Curtis sostennero pubblicamente i propri diversi punti di vista, in relazione alla natura di un tipo particolare di nebulae, ossia quelle che mostravano il disegno a spirale. Quest’ultimo argomento era la chiave di volta su cui Curtis, fresco di nomina a direttore dell’Osservatorio Astronomico di Allegheny (localizzato a Pittsburgh, in Pennsylvania), fondava la sua ipotesi, per la verità condivisa da pochi, che le vedeva essere oggetti esterni alla nostra galassia, quegli “universi isola”, la cui esistenza era stata postulata, solo su basi speculative, più di 150 anni prima, dal filosofo tedesco Immanuel Kant, nella Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Per la verità, Kant non aveva propriamente espresso un’idea originale, ma aveva tratto ispirazione da un lavoro che Thomas Wright, astronomo e architetto inglese, aveva pubblicato, senza riscuotere una grande attenzione, cinque anni prima, nel 1750, in cui, oltre a ipotizzare una forma sferica per la nostra galassia, aveva sostenuto che le nebulae fossero galassie esterne, simili alla nostra. Anche la locuzione “universi isola”, la cui paternità viene generalmente attribuita a Kant, sarebbe stata, in realtà, coniata molti anni dopo, nel 1845, dallo scienziato tedesco Alexander von Humboldt, nella sua celebre opera Il Cosmo.
Nonostante ci fosse stato chi, anche nel passato, aveva sostenuto la probabile esistenza di sistemi stellari esterni al nostro, la maggioranza degli astronomi continuava a opporsi a tale ipotesi, forse spinta inconsciamente dal desiderio di contenere le dimensioni dell’Universo, che per lungo tempo si era limitato a un piccolo sistema, centrato dapprima sulla Terra e poi sul Sole, nel tentativo di confinarlo entro i limiti della nostra galassia, di cui pertanto era necessario salvare ostinatamente l’unicità.
L’introduzione dei rivelatori fotografici in astronomia, avvenuta verso la fine dell’Ottocento, aveva permesso di stabilire che una buona parte delle nebulae mostrava uno strano disegno a spirale. Per la verità, Lord Rosse era già riuscito a individuarlo in alcune nebulose del catalogo di Messier, per mezzo del suo “Leviatano” e senza l’ausilio delle lastre fotografiche, ma l’esposizione prolungata nel tempo, resa possibile grazie a queste ultime, aveva consentito di stabilire che il disegno a spirale era molto più frequente nelle nebulae di quanto si fosse ritenuto in precedenza.
La particolarità di forma delle spirali aveva convinto fin da subito Heber Curtis che dovessero essere oggetti simili alla nostra galassia ed esterni a essa e, per provare questa sua ipotesi, aveva registrato sulle lastre le immagini di più di un migliaio di nebulose, utilizzando quello che, con la sua lente di 91 cm di diametro, era stato per quasi dieci anni, dal 1888 al 1897, il telescopio rifrattore più grande del mondo.
Prima di essere nominato direttore dell’Osservatorio di Allegheny, Curtis aveva, infatti, lavorato per una ventina d’anni all’Osservatorio del Lick e da quel luogo, localizzato un centinaio di chilometri a sud-est dalla città di San Francisco, in California, aveva acquisito il materiale fotografico, che gli aveva consentito di stabilire le caratteristiche distintive delle nebulose a spirale. Dallo studio accurato della loro forma, quale si mostrava attraverso le diverse inclinazioni, che permettevano di identificare al meglio il disegno a spirale quando la nebula appariva “di faccia” (ovvero col disegno esattamente perpendicolare alla linea di vista), oppure il profilo di luminosità della nebula quando questa appariva “di taglio” (ossia col piano equatoriale perpendicolare alla linea di vista), Curtis era riuscito a distinguere la presenza di una banda scura nel piano equatoriale di queste nebulae e aveva ipotizzato che anche la nostra galassia dovesse avere la forma di una spirale. Tale corretta intuizione gli aveva consentito di interpretare un’evidenza osservativa, che era risultata dalla sua grande mole di dati, ossia il fatto che le nebulae a spirale evitassero accuratamente la regione della Via Lattea, che rappresenta la proiezione in cielo del disco della nostra galassia, così come si può vedere da una posizione interna, quale è la nostra. Se anche la galassia in cui ci troviamo aveva la forma e la struttura di spirale, allora l’assorbimento, operato dalla polvere localizzata nel suo piano equatoriale, avrebbe impedito naturalmente la visione di oggetti lontani e deboli, quali sono le galassie esterne.
L’idea che la nostra galassia potesse avere la forma di una spirale non era, del resto, nuova: nel 1852, Stephen Alexander, professore di matematica e astronomia all’Università di Princeton, aveva pubblicato una dissertazione intitolata The Milky Way – a Spiral. La sua era stata soltanto un’ipotesi, che aveva fondato basandosi sul disegno che Lord Rosse aveva effettuato per M99, una galassia che oggi sappiamo essere a 60 milioni di anni luce di distanza dal Sole. Alexander aveva mostrato come, scegliendo opportunamente la forma delle braccia a spirale e ipotizzando che il Sole si trovasse al centro, fosse possibile riprodurre con buona precisione la visione che della nostra galassia abbiamo dalla Terra.
Una cinquantina di anni dopo, nel 1900, il giornalista olandese Cornelis Easton, appassionato di astronomia e di meteorologia, aveva ripreso l’intuizione di Alexander e l’aveva tradotta in un disegno, riuscendo a riprodurre incredibilmente bene quella che in seguito, grazie alle osservazioni in banda radio di una riga, dovuta all’idrogeno allo stato neutro, si sarebbe rivelata essere la forma delle braccia della nostra galassia, regioni in cui l’idrogeno, fondamentale per la formazione di nuove stelle, è particolarmente abbondante.
I tempi, tuttavia, non erano assolutamente maturi e così l’intuizione di Alexander e la rappresentazione grafica di Easton, oltre a non aver avuto, all’epoca, quasi nessun seguito, vengono generalmente ignorate nelle ricostruzioni dell’evoluzione del pensiero astronomico, relativo al XIX secolo.
Shapley, che all’epoca lavorava all’Osservatorio di Mount Wilson, ma sarebbe stato chiamato l’anno successivo a dirigere l’Harvard College di Cambridge, prendendo il posto di Pickering, deceduto nel 1919, era convinto che le nebulose col disegno a spirale appartenessero, al pari delle altre, alla nostra galassia, e il suo argomentare si era incentrato prevalentemente sulle dimensioni di quest’ultima.
Shapley era particolarmente orgoglioso del sistema che aveva escogitato per misurare l’estensione della nostra galassia, che si basava sulle distanze stimate degli ammassi globulari. Col telescopio riflettore di Mount Wilson (avente uno specchio di 1,5 m di diametro) era riuscito a identificare alcune Cefeidi negli ammassi globulari più vicini e, assumendo che per esse valesse la relazione tra il periodo e la luminosità, che Henrietta Leavitt aveva trovato per le Cefeidi della Piccola Nube, ne aveva stimato la luminosità intrinseca. Dal confronto tra quest’ultima e la luminosità che aveva misurato, aveva dedotto le distanze degli ammassi, utilizzando la relazione1![]() illustrata nel Capitolo 5.
illustrata nel Capitolo 5.
Queste gli erano servite per determinare la luminosità intrinseca della stella più brillante di ogni ammasso, che avrebbe usato come “candela standard” negli ammassi più lontani, in cui le Cefeidi non sarebbero state identificabili. Per gli ammassi ancora più lontani, invece, nell’impossibilità di identificare anche la stella più brillante, Shapley avrebbe utilizzato i diametri, assumendo che gli ammassi avessero tutti lo stesso diametro e derivando la loro distanza dal rapporto2Il diametro reale D, il diametro apparente Θ (espresso in radianti) e la distanza d sono legati dalla seguente relazione: «Se la distanza tra due stelle lungo il piano del cielo è pari a D e la loro separazione angolare è inferiore a 1°, esprimendo quest’ultima in radianti, Θ, vale la relazione D / d = Θ, dove d è la distanza tra l’osservatore e il sistema delle due stelle. Da tale relazione si ottiene d = D / Θ». tra il diametro intrinseco e quello apparente.
Il processo di Shapley era stato, oltre che lungo e laborioso, anche soggetto a una grande incertezza, legata alle assunzioni che aveva dovuto fare. Era poco probabile che la stella più brillante degli ammassi globulari avesse sempre la stessa luminosità, così come era ugualmente poco probabile che i diametri degli ammassi fossero tutti uguali. La sovrastima delle dimensioni della nostra galassia operata da Shapley, che col suo metodo era giunto ad attribuirle un’estensione di 80 kpc, pari a quasi tre volte il valore reale (circa 30 kpc), non derivava, però, dal fatto che le sue assunzioni sulla luminosità e sul diametro fossero discutibili, perché, se la stella fosse stata più luminosa di quanto egli aveva assunto, la distanza dall’ammasso globulare sarebbe stata sottostimata, mentre, se fosse stata meno luminosa, sarebbe stata sovrastimata. Qualcosa di analogo sarebbe accaduto con i diametri: se fossero stati più grandi del valore che egli aveva loro assegnato, le distanze sarebbero state sottostimate; se fossero stati più piccoli, sarebbero state sovrastimate. Pertanto, alla fine, gli errori sarebbero stati commessi in un verso e nell’altro e avrebbero prodotto una misura delle dimensioni della galassia non troppo diversa da quella reale, anche se affetta da una grandissima incertezza.