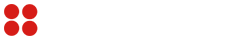Era così che il problema della concordia philosophorum et theologorum – introdotto in Italia dagli umanisti bizantini e accolto come importante argomento di discontinuità con la tradizione filosofica e teologica medievale ridentificata tout-court con la scolastica – veniva affrontato e risolto da Pico a partire dalla tradizione medievale dello Pseudo-Dionigi e dalla dimostrazione del vero significato della trascendenza dell’Uno. Non i Prisci, ma i Recentiores, i filosofi barbari e teutoni, programmaticamente respinti dai platonici italiani del Rinascimento, offrivano al Signore della Mirandola una soluzione moderna e umanistica a un problema che gli umanisti avevano introdotto attraverso una via affatto diversa. Conoscitore dell’aristotelismo arabo, greco e latino, del platonismo e del neoplatonismo, della patristica e della teologia scolastica e tardo scolastica, della mistica ebraica e della tradizione ermetica, corrispondente e spesso amico dei maggiori filosofi e letterati del Rinascimento, Pico torna più volte, nei suoi scritti, sul motivo di un’unica verità, principio di filosofie diverse e oggetto della ricerca di tutte. Attorno a un motivo eminentemente platonico – l’Uno, principio originario della realtà, assolutamente inaccessibile al pensiero eppure termine ultimo cui il pensiero tende, assolutamente altro da ogni cosa creata, ma principio onnipresente che regge nell’essere tutte le creature – non esita a raccogliere testimonianze della tradizione neoplatonica, della patristica, della mistica dionisiana e medievale e della cabala, e a cercare, anche a partire da quelle consonanze in gran parte estranee ai bizantini, elementi di continuità o di coerenza con argomenti aristotelici.
Nel De Ente et Uno, l’opuscolo che, nelle intenzioni pichiane, doveva rappresentare un excerptum di una progettata concordia tra Platone e Aristotele, interpretava il tema della concordanza tra le maggiori tradizioni filosofiche alla luce – ma forse sarebbe più corretto dire, nell’ombra – del concetto dionisiano di trascendenza e, rifacendosi alla disputa del Parmenide platonico, illustrava al Poliziano in quale senso i “trascendentali” logici ens e unum potessero essere predicati delle creature e del Creatore e come il Dio giudaico e cristiano potesse essere detto in un senso partecipe dell’essere e in un altro superiore a esso.
Nel terzo capitolo della Teologia mistica, lo Pseudo-Dionigi aveva delimitato una struttura argomentativa nella quale discorsi differenti intorno a Dio diventavano parimenti sostenibili sulla base di logiche diverse (Dionigi Aeropagita 2009, p. 6091Dionigi Areopagita (2009) Tutte le opere. Traduzione di P. Scazzoso. Saggio introduttivo, prefazioni, parafrasi, note e indici di E. Bellini. Milano: Bompiani.). Si tratta di un itinerario conoscitivo molto simile a quello che Pico traccia nel De Ente et Uno, per congiungere, in un unico discorso a più voci, le filosofie del passato. È attraverso i quattro gradi dell’ascesa verso la “tenebra” in cui Dio ha posto la sua dimora, che si può pervenire a un’autentica sapienza dell’essere assoluto, di una verità che è «sopra a ogni nome che noi possiamo formare, a ogni ragione che possiamo concepire», di un assoluto che possiamo conoscere soltanto «quando del tutto l’abbiamo ignorato» (Pico 2010, p. 2382Pico, G. (2010) Dell’Ente e dell’Uno. Edizione a cura di R. Ebgi. Milano: Bompiani.). Anche per Pico, per affermare la trascendenza di Dio, occorre andare oltre tutti i nomi e le diverse definizioni, oltre l’Uno e l’Essere, e raggiungere la «divina caligo»; anche per lui è una rigorosa argomentazione negativa – Dio «non è verità, né regno, né sapienza; non uno, né unità, né deità, né bontà di spirito» (Pico 2010, p. 238) – quella che lo porta a concludere come la sola conoscenza di Dio sia quella che ne avevamo «quando lo ignoravamo completamente» (Pico 2010, p. 247).
Nulla di più lontano dalla concordia affermativa e ontologica di Pletone, ma una prospettiva non distante, nei suoi presupposti, dalla dimostrazione cusaniana della necessità logica – e non tanto etica e politica – della tolleranza tra religioni monoteiste: l’impossibilità a definire l’infinito di Dio comporta la possibilità di definizioni finite e congetturali, egualmente lecite perché egualmente incommensurabili rispetto all’infinito (Cusano 1972, p. 2063Cusano, N. (1972) Opere Filosofiche. Edizione a cura di G. Federici Vescovini. Torino: Utet.). Vi è un livello in cui i nomi ricavati dalle cose sensibili sono riferibili alle cose divine, spiega ancora Pico nel De Ente et Uno. Una condizione che si realizza solo «purificando i nomi divini da ogni imperfezione terrena» (Pico 2010, p. 236), astraendo cioè dal carattere finito e determinato di ogni singolo attributo applicabile a Dio. Una condizione alla quale corrispondono due ulteriori livelli d’indagine, dei quali uno consiste nel denunciare l’inadeguatezza dei nomi, l’altro nell’accusare la debolezza della nostra capacità di comprendere. Nella Teologia mistica il passo estremo della conoscenza era la «mancanza assoluta di parole e di pensieri» (Dionigi Aeropagita 2009, p. 609); similmente per Pico solo «salendo al quarto gradino entriamo nella luce dell’ignoranza e, accecati dall’oscurità dello splendore divino, ripetiamo a gran voce le parole del profeta: Sono venuto meno nella tua dimora, o Signore» (Pico 2010, p. 238).
La distinzione dei momenti del discorso su Dio, che lo Pseudo-Dionigi traccia ripercorrendo le tappe della sua opera, è per Pico uno dei criteri per conciliare posizioni filosofiche tra loro differenti. Se in un primo momento Dio è rappresentabile come l’Uno o l’Essere, successivamente «denuncia l’inadeguatezza dei nomi» e l’assoluto appare come ciò che «si trova al di là dell’ente, al di là del vero, al di là dell’uno e al di là del bene. Dio infatti è l’essere stesso, la verità stessa, l’unità stessa, la bontà stessa» (Pico 2010, p. 239). Il limite ultimo cui tende la conoscenza umana porta infine con sé la consapevolezza della «debolezza della nostra capacità di comprendere» (Pico 2010, p. 239) e il silenzio di fronte a una verità che si sottrae ad ogni forma di determinazione. Il «nuovo metodo ermeneutico» porta Pico alla conclusione opposta rispetto a quella del De differentiis di Pletone: ricomprese e interpretate all’interno di un discursus adeguato, le tesi sull’Ente e sull’Uno di Aristotele, di Platone e dei (neo)platonici non appaiono in contraddizione tra loro. Se la concordia di Pletone, dalla quale probabilmente anche il Mirandolano prende le mosse, bypassava ogni discussione gnoseologica per fondarsi e garantirsi sui principi dell’ontologia platonica, nel De Ente et Uno si definiscono precisamente i confini della conoscenza razionale e di quella intellettuale, adombrando il limite ultimo che l’uomo incontra nel suo tendere verso la verità. È stata puntualizzata, anche di recente, la sintonia della posizione pichiana con il tema della docta ignorantia sviluppato da Cusano e la presenza di fonti e tradizioni comuni, «filo rosso di tutta la tradizione mistica occidentale» (Ebgi 2010, p. 1374Ebgi, R. (2010) Saggio introduttivo. In: G. Pico, Dell’Ente e dell’Uno, Milano: Bompiani, pp. 43-157.). Sembra però piuttosto il De coniecturis l’opera che più si avvicina alla posizione di Pico. Lì Cusano supera la concezione della dottrina della coincidenza del De docta ignorantia e mostra come ragione e intelletto conducano a livelli diversi un discorso su Dio, il cui termine ultimo è quello mistico. E in effetti, anche per Pico l’anima approssima la presenza divina «quanto più la ragione abbandona la pretesa di essere all’altezza di conoscere Dio» (Pico 2010, p. 173).
Per Cusano alle quattro unità (Dio, l’intelletto, la ragione, il corpo), che sono manifestazione del numero, esemplare simbolico delle cose, corrispondono diversi modi del conoscere:
La mente si rappresenta queste unità mentali con alcuni nomi: chiama Dio la prima mente altissima e semplicissima; la seconda, che può essere la radice che non ha nessuna radice prima di sé, intelligenza; la terza che è il quadrato, contrazione dell’intelligenza, chiama anima; e congettura che l’ultima, che è pesante solidità esplicata e che non complica nient’altro, sia il corpo. Che tutte le cose in Dio sono Dio, nell’intelligenza intelletto, e nell’anima anima, nel corpo corpo, non significa altro che la mente abbraccia tutte le cose o in modo divino, o secondo l’intelletto, o secondo l’anima, o secondo il corpo (Cusano 1972, pp. 212-213).
Al vertice della gerarchia sta non l’ignoranza dello scettico, ma la sapienza dell’idiota: è nei Dialoghi dell’idiota che la definizione di un sapere congetturale viene sviluppata in una dimensione etica in cui umiltà e consapevolezza dei limiti del sapere umano procedono insieme: «questa è forse la differenza tra me e te: tu credi di essere sapiente, benché non lo sia e, perciò, sei superbo. Io invece so di essere un idiota ignorante, perciò sono più umile. Per questo forse sono più sapiente» (Cusano 1972, p. 438). L’itinerario del De Ente et Uno verso la comprensione della «divina caligo» non si allontana molto da questa prospettiva. Parafrasando e capovolgendo il giudizio di Masai su Pletone, si potrebbe affermare che, nel De Ente et Uno, la concordia delle tradizioni, affrontata a partire dal problema dell’impossibile conoscenza di ciò che non ha limiti, costituisca un problema critico assai più che ontologico. Di più: proprio la riflessione critica sui modi del conoscere consente a Pico di riempire di contenuto la concezione dell’indeterminatezza ontologica (indiscreta imago) dell’uomo difesa nella prima parte dell’Oratio. Non a caso, per identificare l’essenza dell’uomo, Pico sceglie l’aggettivo indiscretus che ha la propria radice nel participio perfetto di discernere, e cioè un verbum putandi che serve a definire lo statuto più proprio della natura umana. Si potrebbe allora affermare che, diversamente da Pletone, ma diversamente anche dal Valla, in Pico i due piani, quello gnoseologico e quello della definizione ontologica, si presuppongono a vicenda. Si presuppongono rispettivamente una volta sussunti, l’uno e l’altro, nelle trame di una rinnovata antropologia. Onnipotenza divina e fato, libertà umana e necessità naturale, non si oppongono come nella concezione di Pletone – in ciò coerente con l’imago mundi medievale – ma si implicano vicendevolmente fino a riconoscersi l’una specchio dell’altra.
Straordinariamente perspicuo e straordinariamente originale, nonostante le iterate citazioni bibliche, ermetiche e platoniche, il racconto della creazione del mondo e dell’uomo nella Oratio de hominis dignitate. Dio fabbrica l’universo con un atto di libertà assoluta e secondo le leggi di un’arcana sapienza. Ma quel principio, unico e assoluto di libertà che è il Dio Pantocrator, si scopre imperfetto, mancante di qualcosa (desiderabat) e pertanto necessitato dal suo stesso bisogno a fare qualcosa che l’arcana sapienza non aveva previsto. Questo “imprevisto” paradosso della creazione è l’uomo, non immagine del padre, ma «universi contemplator»:
Perciò, compiuto ormai il tutto, come attestano Mosè e Timeo, pensò da ultimo a produrre l’uomo. Ma degli archetipi non ne restava alcuno su cui foggiare la nuova creatura, né dei tesori uno ve n’era da largire in retaggio al nuovo figlio, né dei posti di tutto il mondo uno rimaneva in cui sedesse codesto contemplatore dell’universo (Pico 1942, p. 1045Pico, G. (1942) De Hominis dignitate, Heptaplus, De Ente et Uno e scritti vari. Edizione a cura di E. Garin. Firenze: Vallecchi.).
Anche l’onnipotenza di Dio, il suo benefico amore, la sua divina liberalità richiedono uno specchio nel quale riconoscersi, e lo specchio che il Sommo Padre è necessitato a produrre per identificarsi come perfetto artefice dell’universo è un essere «capace di afferrare la ragione di un’opera sì grande, di amarne la bellezza, di ammirarne la vastità» (Pico 1942, p. 1046Pico, G. (1942) De Hominis dignitate, Heptaplus, De Ente et Uno e scritti vari. Edizione a cura di E. Garin. Firenze: Vallecchi.). Per questo, nell’Oratio, l’ultima fattura del creatore, Adamo, è diversa da tutte le altre: priva di prerogative proprie, non condivide la natura limitata degli altri enti; sciolta dalla legge di natura, è unicamente costretta alla propria stessa libertà: «non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso, quasi libero e sovrano artefice ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che avresti prescelto» (Pico 1942, p. 107).