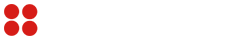Pico non esclude che sia possibile riconoscere fino in fondo, cioè «in modo assoluto», la trascendenza. Ma la via è un’altra rispetto a quella della ragione e del discursus, anche della ragione più sottile e del discorso più raffinato e filologicamente attrezzato. Per affermare fino in fondo la trascendenza di Dio occorre porlo oltre tutti i nomi, oltre all’Uno, oltre all’Essere, oltre a tutto, nella «Divina Caligo». Attraverso quattro gradi dell’ascesa verso quella tenebra in cui Dio ha posto la sua dimora, perveniamo all’ultimo grado ove comprendiamo che l’essere assoluto «non solo è superiore a quei nomi, ma si trova oltre qualsiasi nome che possa essere da noi concepito e supera ogni nostra possibile conoscenza» (Pico 2010, p. 246). In quella tenebra in cui vive Dio cadono tutte le opposizioni concettuali e all’uomo non resta che il silenzio.
Ma, a ben vedere, questa strada che, nel De Ente et Uno, è quella tracciata dalla trascendenza neoplatonica dello Pseudo-Dionigi, non è diversa da quella che guida il camaleonte dell’Oratio, oltre la ragione e oltre l’intelletto, oltre gli animali celesti e oltre gli angeli, al di sopra di tutti gli enti; raccolto nel centro della propria stessa unità e, in questa scelta, una cosa sola con Dio:
ma se, non contento della sorte di nessuna creatura, si raccoglierà nel centro della sua unità, fatto uno spirito solo con Dio, nella solitaria caligine del Padre colui che fu posto sopra tutte le cose starà sopra tutte le cose (Pico 1942, p. 107).
Non è lo Pseudo-Dionigi e nemmeno Aristotele o Tommaso a suffragare, nell’Oratio, questa ascesa alla «Caligine Divina», ad aprire le porte di questa trascendenza simile, per l’uomo, a una trasmutazione, ma sono l’Asclepio ermetico, le metamorfosi celebrate dagli Ebrei e dai Pitagorici, e finanche Maometto: tutti semi di una concordia che tiene insieme i Prisci, i profeti, Aristotele e Platone, Averroè, lo Pseudo-Dionigi e Tommaso senza esaurirsi in nessuno di loro, ma anzi, destinata a germogliare nel tempo e ad arricchire indefinitamente l’indiscreta imago dell’umana sapienza.
Il brevissimo capitolo del De Ente et Uno dedicato alla materia offre due preziose indicazioni in vista della filosofia della concordia.
Lo Pseudo-Dionigi torna prezioso per confutare una concezione della trascendenza come opposizione assoluta dell’Uno all’Essere; concezione, questa, che rende inspiegabile il passaggio dall’Uno, che è oltre l’Essere, alla materia, e altrettanto inspiegabile la tesi per la quale la materia non è, ma è, tuttavia, unità. Il problema che vede Pico è quello di ogni teodicea che tenti il passaggio dall’Uno al molteplice e dal trascendente alla materia. La chiamata in causa, oltre allo Pseudo-Dionigi, di neoplatonici come Simplicio e Giamblico, mostra un Pico determinato a confutare non il neoplatonismo, ma un certo neoplatonismo e a farlo mettendo in pista altre fonti neoplatoniche. Lo Pseudo-Dionigi serve ad accreditare una diversa idea di trascendenza rispetto a quella di Plotino e di Ficino; Simplicio torna qui utile per smentire che sia Platone, sia Parmenide, sia quanti, tra i platonici, hanno difeso Parmenide, abbiano sostenuto – in senso assoluto – il primato dell’Uno sull’Ente. Giamblico «grande tra i platonici» è richiamato a sostegno della tesi pichiana per la quale «la materia prima […] non solo non è una, ma è quella molteplicità radice di tutto quanto vi è di molteplice nelle cose» (Pico 2010, p. 251). Di nuovo sul concetto di materia prima, Pico si applica nel tentativo di dimostrare la convergenza tra Platone e Aristotele non già aristotelizzando Platone, ma interpretando Platone attraverso fonti neoplatoniche, selezionate oculatamente e, simmetricamente, sceglie luoghi platonici coerentemente riconducibili ai problemi discussi e ne tralascia altri che risulterebbero più complicati da armonizzare. Non è Aristotele a essere letto in una prospettiva platonica, né Platone a essere aristotelizzato, ma è piuttosto Platone a confutare se stesso in vista di una lettura coerente con il principio stesso della concordia. Il che equivale a dire che quegli elementi di “verità perenne”, che determinano, anche entro il divenire storico, la concordanza tra concezioni filosofiche e teologiche diverse, non risiedono nel pensiero di Platone, di Aristotele o di qualunque altro filosofo, ma in ciò che determina la concordia stessa, vale a dire, la comune umanità che unisce, nel tempo e nello spazio, i filosofi e i teologi prima ancora delle teologie e delle filosofie. “Comune umanità” che, ben inteso, non può essere definita in termini affermativi e unilaterali, ma come indifferenziata possibilità di farsi del divino camaleonte.
Lo stesso «metodo ermeneutico» viene applicato negli ultimi capitoli nei quali Pico rende compatibili gli attributi di Dio e delle cose che vengono dopo Dio. Il trattato si chiude con un explicit apparentemene autobiografico, nel quale l’itinerario verso Dio passa non solo attraverso la conoscenza – o attraverso una sorta di dotta ignoranza – ma anche attraverso un itinerario di purificazione morale che comporta il progressivo distacco dalle pulsioni corporee, dai vizi e dall’asservimento della ragione al senso. In verità, più che a un’esuberanza esistenziale e biografica, l’ultimo capitolo non è altro che quella riconversione del motivo teoretico ed epistemologico verso un’antropologia che torna a essere la sola via per uscire dalla contraddizione, o per meglio dire, la sola via per rendere coincidenti le opposizioni.
È l’uomo, il filosofo, che nella ricerca nelle cose divine deve innanzitutto ricercare la somiglianza con Dio nel possesso dell’unità, della verità e della bontà. Nell’Oratio, l’uomo, purché «in unitatis centrum suae se receptus» (Pico 1942, p. 106), non è altro da Dio; non è la creatura opposta al creatore, la necessità opposta alla libertà, ma è lo specchio dell’identificazione con Dio. In tutti gli uomini v’è infatti qualcosa di divino che seguendo l’amore delle cose del cielo porta oltre la sfera dei Cherubini. Ma questa divinità insita nell’uomo non esclude né contraddice ma piuttosto si compone e si coniuga, con la sua carnalità, con quella pletora di impulsi e di vizi, che spinge affinché si unisca non a Dio, ma alla terra. La declinazione antropologica del problema metafisico e mistico, o meglio ancora, l’uomo che emerge dall’antropologia pichiana diventa il modello stesso del suo metodo esegetico. «Quarto mondo» nell’Heptaplus, ciò che approssima Dio più ancora degli angeli perché, come Dio, è tutte le cose sebbene «come termine medio» e non come «principio», il camaleonte dell’Orazione, che può diventare indifferentemente bruto o una cosa sola col divino, è soprattutto l’essere obbligato soltanto dal proprio arbitrio, colui che rivela a Dio come libertà e necessità non si oppongano, ma siano l’una la proiezione estrema dell’altra: un’indiscreta imago che è il paradigma e insieme il simbolo di una concordia che poggia sulla differenza e sulla pluralità.
Il significato delle ultime pagine del De Ente et Uno va ben oltre la biografia del Mirandolano e rimanda al cuore stesso del suo pensiero. Fin dagli studi padovani, Pico aveva riflettuto intensamente sul rapporto tra l’Uomo e Dio e sul modo in cui l’uomo può congiungersi alla divinità. Sottomettendo i nostri vizi a quella scintilla di divino che è in noi, possiamo «ad ipsum tendentes illi aliquando copulemur» (Pico 2010, p. 270). Si tratta di qualcosa di simile a quella copulatio dell’intelletto separato con l’intelletto agente di cui parlavano gli averroisti a Padova proprio negli anni in cui vi studiò Pico. E l’averroismo, detestato dagli amici fiorentini, al quale Pico era stato introdotto da Nicoletto Vernia e, soprattutto, da Elia del Medigo, negli anni padovani (1480-82), è un’altra tessera essenziale non solo della formazione pichiana, ma soprattutto del suo criterio di concordia. L’averroismo al quale Elia lo introduce è per Pico una ulteriore interpretazione di Aristotele, diversa da quella della scolastica latina, ed è un esempio di aristotelismo arabo disomogeneo rispetto a quello di Avicenna e alla contaminazione che quest’ultimo aveva proposto tra il pensiero di Platone e di Aristotele.
Bruno Nardi analizzò alcune delle Conclusiones riconducendole ai problemi sorti in grembo all’aristotelismo averroista e relativi alla possibilità dell’intelletto umano di congiungersi all’intelletto agente. Secondo Nardi, Pico identifica l’intelletto agente con Dio e sostiene che per l’intelletto umano sia difficile, ma non impossibile, congiungersi con quello (Nardi 1958, pp. 127-1461Nardi, B. (1958) Saggi sull’aristotelismo padovano, Firenze: Sansoni.). Per una via diversa Eugenio Garin riconosceva la dignità dell’uomo di Pico e la sua originalità nell’universo, nel suo potersi fare tutto pur non essendo nulla: «mentre in ogni ente operari sequitur esse, nell’uomo esse sequitur operari» (Garin 1937, p. 2002Garin, E. (1937) Giovanni Pico della Mirandola. Vita e dottrina, Firenze: Le Monnier.). Dignità che non è restituita dalla definizione, ma dall’infinita tensione del «divino camaleonte» che si fa pianta e sasso, o che nel desiderio di conoscenza s’innalza a Dio.
La posizione di Pico, soprattutto negli anni successivi al fallimento del progetto di discussione delle Conclusiones e in seguito all’arresto, innestò, su questi motivi appresi a Padova, elementi nuovi. Ritiene cioè che la dottrina averroista dell’unità dell’intelletto possa in qualche modo conciliarsi con l’idea di una coscienza individuale umana destinata a sopravvivere oltre la morte (Nardi 1958, p. 375). Nella settima esposizione dell’Heptaplus Pico spiega come, accanto a una felicità raggiungibile «per le vie della natura», ne esista un’altra «che possiamo raggiungere per le vie della grazia» (Pico 1942, p. 327). Proprio il concetto di grazia, che trova il suo pieno valore in relazione a una cristologia fondata sulla centralità dell’incarnazione (Nardi 1958, p. 145), è il passaggio che conduce fuori dall’intellettualismo averroista e apre una via diversa per la salvezza dell’uomo. Il rimprovero che muove Pico nelle ultime pagine dell’Heptaplus è indirizzato proprio a chi misconosce il ruolo salvifico della grazia del Cristo, a quei «saputelli», «sciocchi» e «fannulloni», «che chiamandosi filosofi mentre non lo sono, si affrettano a ridere della grazia e della felicità soprannaturale come fossero vani nomi e favole da vecchierelle» (Pico 1942, p. 327). La felicità è quindi «il ritorno di ciascuna cosa al suo principio», «il sommo bene», la vicinanza al «medesimo Dio uno, onnipotente, benedetto, migliore di tutte le cose che possono esistere o essere pensate» (Pico 1942, p. 327). Averroè, Avicenna, Abu Bacer, Alessandro e i platonici possono pretendere di parlare solo della felicità naturale, ma questa loro felicità è solo «un’ombra» della vera felicità.
Come la dignità umana poggia sulla possibilità dell’uomo di congiungersi a Dio, così a tale dignità è indispensabile la libertà. L’uomo sceglie liberamente di lasciarsi guidare alla felicità dalla grazia divina e in questo trova quel valore che lo distingue e lo sovraordina per magnificenza persino dalle orbite celesti, costrette entro la necessità del moto meccanico: «ci differenziamo dal cielo – scrive Pico nell’Heptaplus – perché esso è mosso dalla necessità della sua natura, mentre noi ci muoviamo secondo la nostra libertà» (Pico 1942, p. 337).
Non è possibile non soffermarsi sul fatto che la grazia che Pico rivendica contro Greci e arabi non ricade entro i domini di una trascendenza stricto sensu, ma implica piuttosto una carnalità, una tridimensionalità corporea che non ha, in sé, nulla di mistico o di astratto. Nell’Heptaplus è qualcosa di simile al braccio potente di Dio, capace di attrarre a sé l’uomo vincendo la gravità del suo corpo richiamato in basso, dalla terra. La felicità procurata dalla grazia non solo non è la felicità naturale, ma non è nemmeno la beatitudine angelica: la gratuità libera di Dio ha necessità di un corpo pesante al quale applicarsi. È un’altra declinazione di quella simmetria e di quella reversibilità tra Uno-Dio e Uno-Uomo, sulla quale si è già insistito a proposito della Oratio, alla quale Pico si rifà ogni qual volta debba reagire a derive deterministiche più o meno larvate. Come la libertà di Dio ha bisogno dell’uomo per rendersi manifesta, così la libertà dell’uomo è la sola necessità impostagli dal creatore; come l’uomo ha bisogno del braccio vigoroso della grazia divina per contrastare una gravità che lo costringerebbe al vincolo della necessità naturale e realizzare la propria libertà, così alla trascendenza di Dio serve un corpo incarnato al quale rivolgere il dono gratuito della salvezza, gesto d’amore incondizionato al quale è richiesto l’uomo come condizione per esprimersi. Un gioco di specchi e di rimandi, di vincoli e di limiti, che non rende l’uomo un dio terreno, né fa di Dio la proiezione estrema o «l’eccellenza della umanitade» – l’espressione è di Giordano Bruno negli Eroici Furori – ma che vincola tra loro creatore e creatura, conoscenza e conoscibile, limite e illimite. Così, se è Dio l’unità assoluta che, come tale, sovrasta gli enti, è l’uomo, anche di fronte al mistero della salvezza che trascende ogni finita comprensione, che rivela l’impossibile reductio ad unum di qualunque prospettiva dogmatica o monistica.